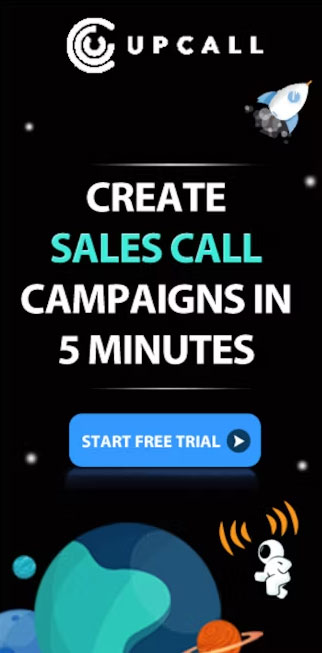Il Mastino Napoletano discende dal grande molosso originatasi dal ceppo tibetano . Razza imponente, che combatteva con le Legioni romane, si è conservato maggiormente, lungo due millenni, nella campagna vesuviana.
E’, da sempre, un cane dal carattere forte, leale e diventa aggressivo o mordace solo per valide motivazioni in quanto difensore della proprietà e delle persone che lo amano, soprattutto dei bambini, se addestrato tra i 3 e i 4 mesi.
“Mantello formato da pelo corto di colore grigio, piombo, nero, mogano, fulvo (e un tempo anche bianco sporco), tipiche rughe (quasi a sottolineare l’antichità della razza ) a conferire l’espressione unica ed affascinante tipica di questo cane ed a formare una caratteristica giogaia sotto il collo; la testa deve essere imponente soprattutto nei soggetti maschi. “

Federico Vinattieri, esperto allevatore di Mastini Napoletani ci racconta come il Mastrino napoletano fu riselezionato nel 1947
“Nell’anno 1946 il Dottor Piero Scanziani, noto scrittore che nei successivi anni divenne uno dei più importanti cinofili italiani, si aggirava nel territorio partenopeo alla ricerca dell’antico molosso del quale aveva sentito parlare e che veniva descritto in molte storie e leggende del passato. Il Molosso italiano, così veniva da lui menzionato. E’ stata giustamente attribuita a Scanziani la “paternità” della razza, dato che fu lui a ricostruirne la genetica e fu lui a proporlo per la prima volta alla esposizione di Napoli alla fine degli Quaranta, con grande stupore di tutti i giudici e allevatori presenti; tre anni dopo apparve sulla copertina della rivista “Cani di tutte le razze” l’immagine della testa di un Mastino Napoletano, che riscosse le maldicenze di tutti i cinofili scettici, che non volevano credere nella “resurrezione” del molosso arcaico. In seguito, con il trascorrere degli anni, si dovettero ricredere. Così venne descritto da Scanziani nel suo famoso racconto “Viaggio intorno al Molosso” scritto a Sagno, il 12 ottobre del 1974, nel quale lo scrittore ricorda il suo primo incontro:
<< – Lo riconobbi all’istante: era uno dei cento che Paolo Emilio il Macedonico aveva portato in Roma al suo trionfo. Era il gran cane d’Epiro, figlio degli assiri, nipote dei tibetani, era il Molossus. Guaglione dall’alto dei suoi secoli mi fissava imperturbabile, …>>. Suggestiva descrizione di un incontro che avrebbe cambiato la vita a Piero Scanziani.
Ma quando venne menzionato il Mastino Napoletano per la prima volta nello scorso secolo?
Questa è una domanda interessante, alla quale dovevo riuscire a trovare una risposta. Dopo svariate letture, la ricerca mi ha condotto ad una vecchia rivista quindicinale illustrata “Diana” del 31 Ottobre 1933 (n. 20 – anno XXVIII) che all’epoca trattava cinofilia generale, caccia, tiro e pesca, (che fa parte del mio archivio) nella quale lessi una sorprendente rivelazione. Un certo signor Marcenaro M. Adriano, scrisse un articolo nel 33? dedicato alle razze canine italiane, intitolato “Cinofilia: i nostri buoni cani”. In questo articolo il Signor Marcenaro si soffermo soprattutto sulle razze da pastore e sulle razze da caccia; ma in un paragrafo l’attenzione viene catturata da un particolare interessante: Marcenaro scrive il seguente discorso:
<< – Qualunque sia la causa del fatto che constatiamo, non è meno vero che le razze canine nostrane sono poche, molto poche. Tre da caccia: bracchi, spinoni, segugi; tre di lusso: volpini, piccoli levrieri, barboni; due di utilità: il cane da Pastore di Bergamo o delle Alpi ed il Cane da Pastore di Maremma o degli Abruzzi. >>; dopo Marcenaro aggiunge:
<< – Se poi desideriamo abbondare potremo includere del presente breve elenco, il Mastino di Napoli, certo discendente dai grandi cani da presa del periodo medioevale ma che, quanto a purezza e fissità di razza, lascia molto a desiderare. >>
Questa ultima frase è la prova indiscutibile che fu il Signor Marcenaro a parlare del mastino in via ufficiosa per la prima volta nella cinofilia moderna. La sua precisazione sulla scarsa purezza e fissità di tipo, pur riconoscendone l’antica discendenza, è assolutamente comprensibile, in quanto, come detto in precedenza, solo dopo il primo lavoro di selezione di Scanziani fu possibile ammirare soggetti di apparente omogeneità, ma ciò ebbe inizio più di 15 anni dopo l’affermazione di Marcenaro.
Il lavoro di Scanziani e successivamente l’operosità di Mario Querci, riuscirono a plasmare il mastino fino a farlo divenire l’affascinante razza che oggi possiamo tutti ammirare. Chissà come ai giorni d’oggi Marcenaro avrebbe descritto quella razza che aveva in lui fatto emergere così tanta titubanza e dubbi di effettiva purezza.